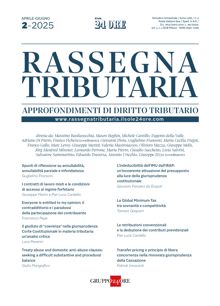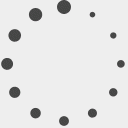Estratto: Con la sentenza in commento, la Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione della disciplina domestica sui prezzi di trasferimento costituita dall’art. 110, comma 7, TUIR in combinato disposto con l’art. 9, comma 3, sostenendo l’assenza di qualsiasi forma di primogenitura di un modello di contrasto al transfer pricing sugli altri. Tale decisione ha adeguato l’ordinamento fiscale domestico agli standard emersi nella migliore prassi internazionale, ha superato la divergenza del concetto di “valore normale” con il principio di libera concorrenza presente in precedenti arresti, nonché la rigidità della formulazione previgente dell’art. 110, comma 7, che, proprio per tale ragione, è stato oggetto di riforma con il D.L. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno del 2017).
Abstract: With the commented decision, the Italian Supreme Court ruled on the interpretation of transfer pricing’s home legislation, claiming the absence of any sort of prominence concerning a transfer pricing model over the others. The aforementioned decision adapted the italian legal order so that it complies with OECD Transfer Pricing Guidelines, overcoming the divergence between fair value and the arm’s length principle previously stated in several decisions of the Supreme Court and the strictness of former article 110, paragraph 7, of the Income Tax Consolidated Act, which was amended because of said reason by Decree-Law no. 50/2017 (converted by law no. 96 of 21 June 2017).
* Gli articoli contrassegnati da un asterisco sono stati giudicati positivamente, su base anonima, da un membro del Comitato di valutazione designato a rotazione. Imposte dirette – Prezzi di trasferimento – Valore normale – Libera concorrenza – Accertamento – Art. 110, comma 7, TUIR – Art. 9, comma 3, TUIR Il combinato disposto tra l’art. 110, comma 7, e l’art. 9, comma 3, TUIR – nella versione ante d.l. n. 50/2017 – deve interpretarsi nel senso di dover escludere qualsiasi forma di primogenitura del metodo del confronto del prezzo (CUP) rispetto agli altri metodi per la valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento indicati dall’OCSE. Il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR, dunque, recepisce il principio di libera concorrenza così come delineato nella miglior prassi internazionale e sollecita il contribuente ad applicare il metodo che risulta essere più adatto alla fattispecie concreta.
di Patrick Innocenti